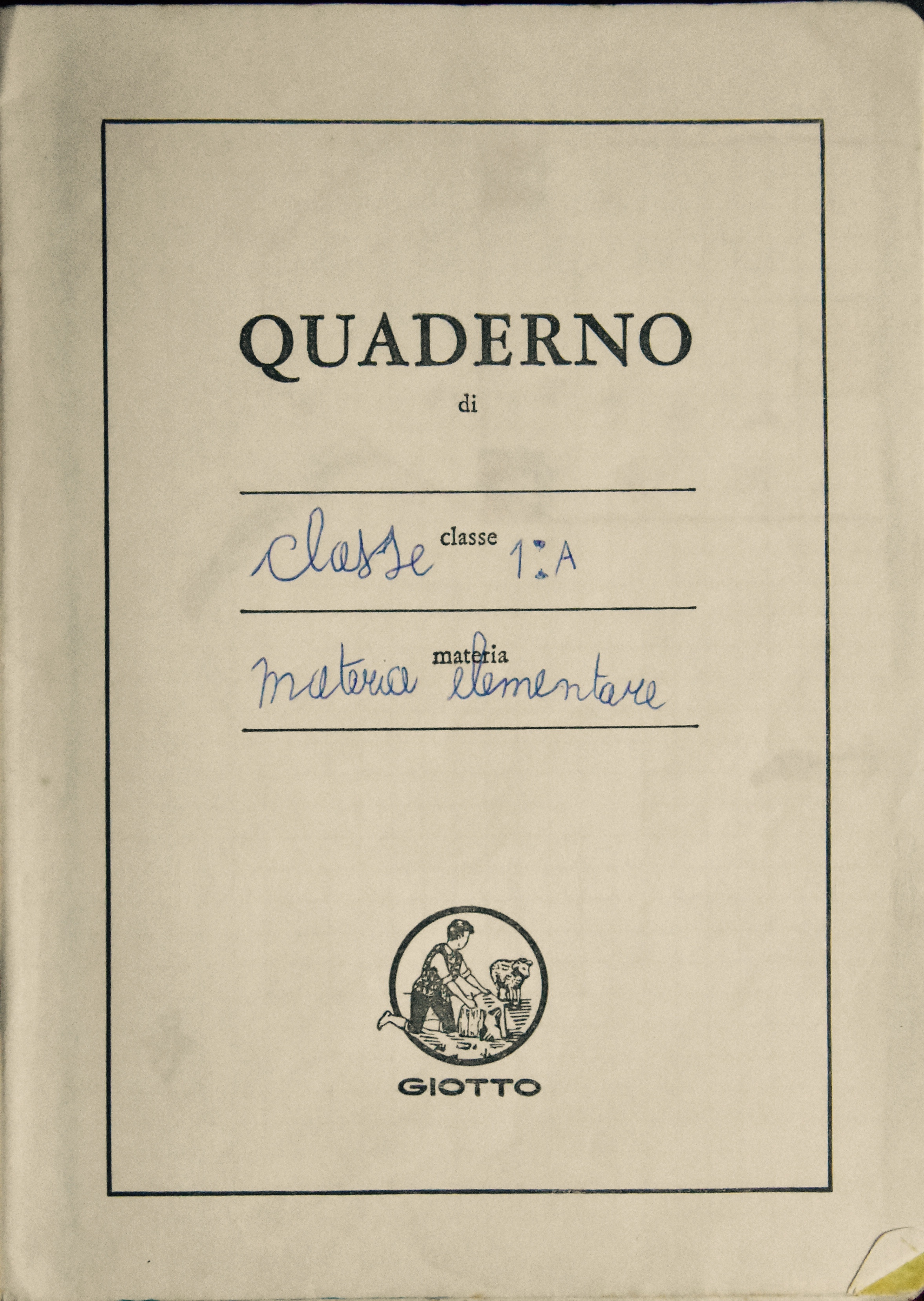«La nostra eredità non è preceduta da alcun testamento».
René Char
Il discorso pubblico sulla scuola soffre di due patologie opposte e, paradossalmente, complementari: da un lato, un presentismo esasperato che fa sobbalzare di fronte a ogni rilevazione statistica e gridare allo scandalo intellettuali e giornalisti che improvvisamente scoprono la questione meridionale, l’analfabetismo funzionale, la dispersione scolastica, elementi di fatto strutturali del nostro sistema scolastico sui quali da decenni vengono impostate politiche pubbliche evidentemente non risolutive. Dall’altro lato, ognuna di queste rilevazioni è invariabilmente accompagnata da un equivalente passatismo, una nostalgia che usa la storia come richiamo generico e astratto dividendo il tempo fra un prima e un dopo, una mitica età dell’oro nella quale «facendo spazio al retaggio umanistico, il cuore dell’istruzione è stato un ponte fra il presente e il passato» e un eterno presente nel quale questo passato è stato calpestato e con esso la sua autorevolezza, «sicché la nuova scuola che ha deciso di «aprirsi alla vita e alla società» puntando proprio per questo sulle discipline scientifiche, ha sentito il bisogno di mettere a punto un diverso principio d’autorità e un nuovo principio di autolegittimazione. Un principio che essa crede d’aver individuato nella «democrazia», perlopiù intesa come la presunta fine di ogni costrizione» (Galli della Loggia, 2019).
In questo tipo di discorso, la storia riveste una funzione fondamentale: il dirsi storici o il richiamarsi alla storia infatti agisce come principio di autorità nel momento in cui si stabilisce come dato di fatto l’esistenza di una cesura temporale. Si “scopre” un problema nel sistema scolastico del presente e se ne individua l’origine in un punto x del passato; si dice: tutto ha avuto inizio nel 1968, o con la riforma Berlinguer, o con le tesi per l’educazione linguistica democratica, senza tuttavia portare alcun dato specifico o fonte che lo dimostri, ma solo basandosi appunto su quel principio di autorità che esime lo storico o la storica in questione dal farsi portatore di un metodo di lavoro e di ricerca. Mettere due date, individuare uno spartiacque, citare tre esempi e il gioco è fatto, chiunque avrà la sensazione di trovarsi di fronte a un discorso sorretto da basi storiche quando in realtà quello che viene messo in moto è esattamente il contrario: una contemplazione necrofila del passato che per essere accettata necessita di un atto di fede.
Adolfo Bioy Casares e Jorge Luis Borges in una delle loro «Cronache di Bustos Domecq» giocano a ricostruire gli atti e la discussione di un immaginario congresso mondiale degli storici, tenutosi a Pau, dal titolo La storia è una scienza o un’arte? Fazioni opposte si scontrano, brandendo «ciascuna come propri», gli stessi nomi: «Tucidide, Voltaire, Gibbon, Michelet». La conclusione a cui si arriva è unanime: la storia è, in realtà, un «atto di fede».
Infatti, scrivono i due argentini, più di uno storico «ha stabilito per sempre che le scienze esatte non si basano sull’accumulazione statistica; per insegnare alla gioventù che tre più quattro fanno sette non si sommano quattro meringhe con tre meringhe, quattro vescovi con tre vescovi, quattro cooperative con tre cooperative, e neppure quattro stivaletti di vernice con tre calze di lana; intuita finalmente la legge, il giovane matematico afferma che, invariabilmente, tre più quattro danno sette e non ha bisogno di ripetere la prova con caramelle, tigri avvezze alla carne umana, ostriche e telescopi. La medesima metodologia esige la storia». Così fanno in molti quando parlano di scuola.
La storia. La storia è innanzitutto un metodo, un come non un cosa. Questo metodo si fonda su due unità di tempo: il tempo lungo della durata e il tempo breve dell’evento. L’individuazione di questi due fattori temporali unita all’uso critico e trasparente delle fonti fa un di un discorso un discorso storiografico. (Non solo: la storia è scienza di contesti: e anche in questo caso serve a capire la scuola, che riflette sempre un contesto).
Il metodo storico serve moltissimo nel discorso pubblico sulla scuola proprio per quei tic individuati sopra (la schizofrenica dicotomia fra presentismo e passatismo): serve perché ci aiuta a vedere quali fenomeni vengono da lontano e sono ormai diventati strutturali al sistema scolastico e quali invece nascono dalle trasformazioni sociali o dalle scelte politiche contingenti. Serve perché aiuta a ridimensionare (presunte) emergenze e a mettere in luce cosa non è stato fatto che avrebbe potuto esserlo e cosa si può fare adesso. Serve, infine, per dare un senso politico alla parola crisi che va a braccetto con la parola istruzione fin dai tempi della legge Casati, ma che in ogni momento storico ha indicato, in effetti, qualcosa di diverso.
In ogni momento della storia della scuola in Italia, scrive Monica Galfré, il dibattito sulla crisi dell’istruzione è stato un dato con cui confrontarsi, anche se si è rivelato assai più vischioso e contraddittorio che in altre realtà, proprio per questo costante richiamo al passato, che è stato piegato per formulare diagnosi diverse se non opposte. Tale fenomeno si è esasperato in anni recenti: «se taluni attribuiscono gli alti tassi di dispersione al perdurare di una severità ormai anacronistica, sopravvivenza di un sistema selettivo, altri denunciano vibratamente la perdita di autorevolezza e di autorità della scuola, non senza punte di rimpianto. Ma dire cosa davvero essa sia diventata è molto difficile: anche per effetto della parziale autonomia degli istituti, il pianeta scuola tende a differenziarsi sempre più al suo interno; e, rispetto alla tradizione, non si può dire che ne sia totalmente risucchiato, né che l’abbia cancellata» (Galfrè, 2017).
Le riforme scolastiche. È ormai abitudine guardare il cammino dell’istruzione pubblica secondo lo schema messo a punto dal sociologo Philip Brown, che ha rilevato come l’Occidente sia stato investito negli ultimi cento anni (e poco più) da un processo di scolarizzazione che può essere sintetizzato nel modello delle «tre ondate»: la prima di esse, negli ultimi decenni dell’Ottocento, volta a confermare le gerarchie sociali, coincide con la sanzione dell’obbligo, con il processo di nazionalizzazione e con la richiesta di manodopera qualificata legata alla seconda rivoluzione industriale. La seconda culmina nella crescita dirompente degli anni Sessanta, durante i quali l’istruzione appare il volano decisivo dello sviluppo e tra i suoi obiettivi l’integrazione tende a prevalere sulla selezione. La terza, negli anni Ottanta del Novecento, quando l’incipiente globalizzazione e il neoliberismo mirano a trasformare l’istruzione in un bene privato grazie al quale le classi medio-alte possano riprodurre il proprio privilegio.
Ovviamente il modello di Brown individua una tendenza generale, quella di lungo periodo; allo storico il compito di mettere in luce, all’interno dei diversi contesti nazionali e delle diverse forme di welfare legate all’istruzione, quali sono stati i caratteri originali in tema di istruzione di ogni realtà specifica e soprattutto quali le fratture periodizzanti. Sull’ultimo punto infatti, l’esperienza italiana non può non risultare estremamente contraddittoria. Come nota Mauro Piras l’ultima fase, che continua a essere segnata anche da tendenze inclusive (per esempio nei confronti dei migranti e dei disabili, nell’abbassamento della dispersione e delle bocciature) nel caso italiano è proprio quella in cui esplode la scolarizzazione di massa (solo negli anni 2000 la percentuale di ragazzi tra i 14 e i 19 anni iscritti a scuola supera il 90%).
Malgrado i tentativi dei governi di destra di adempiere al diktat neoliberista (De Michele, 2010), infatti, la scuola italiana ancora resiste da un lato nel suo progetto di inclusione sociale e rimozione degli ostacoli per il pieno adempimento della cittadinanza (art. 3 Cost.), dall’altro sembra affogare in problemi mai risolti che affondano le radici nel mancato adempimento delle riforme (seppur parziali) degli anni Sessanta e Settanta più che in un recente progetto politico dell’OCSE, organizzazione sovranazionale indicata da alcuni osservatori come mandante delle politiche neoliberiste in fatto di scuola. Eppure tutto questo raramente viene messo in luce e al modello di Brown si rifanno in modo acritico sia alcuni movimenti di sinistra sia alcuni intellettuali di destra, uniti contro il Moloch del riformismo nel suo complesso, delle competenze, della scuola asservita al capitale (su questo è davvero paradossale la coincidenza fra commentatori più conservatori e altri più movimentisti) (Vigilante, 2019).
Questo contraddittorio ed eterogeneo schieramento che in qualche modo stabilisce l’ordine del discorso contemporaneo sulla scuola è tenuto insieme dal mito «della riforma organica, che domina l’intero Novecento: a lungo invocata nell’età liberale, è realizzata dal fascismo appena nato ed è poi inseguita nel corso di tutta la cosiddetta “Prima Repubblica”. Un mito, appunto, che nella realtà ha dovuto cedere il passo a interventi di più modesta entità affidati all’esecutivo e talvolta anche solo all’amministrazione. L’idea della grande riforma entra in crisi con la fine del secolo breve e del sistema dei partiti uscito dalla Resistenza, che è anche crisi dell’idea stessa di Stato nazionale e dei sistemi scolastici tradizionali intesi come qualcosa di unitario e organico. Ancora spendibile sul piano politico, l’obiettivo della riforma trova però un ostacolo insormontabile nell’articolazione della società di massa e nelle progressive «”dimissioni dello Stato” che negli anni Ottanta del Novecento le concezioni neoliberiste suggeriscono un po’ ovunque» (Galfré, p.25).
Di riforme organiche della pubblica istruzione ce ne sono state, di fatto, soltanto due: la legge Casati del 1859 e la riforma Gentile, attuata all’indomani della marcia su Roma, ma immaginata negli anni che precedono l’avvento stesso del fascismo da intellettuali come Giuseppe Lombardo Radice e Giovanni Gentile. Nessun intervento legislativo repubblicano l’ha mai messa radicalmente in discussione, a partire dal cardine intorno a cui la riforma stessa ruota, ossia l’istruzione secondaria superiore. Da Casati a Gentile l’istruzione superiore, la scuola secondaria, diventa il luogo cruciale di formazione delle élite e, soprattutto, di quel più vasto ceto medio che lentamente diventa “italiano”. (Raicich, 1996).
Così la riforma Gentile ha modellato il sistema scolastico su un predominio della cultura classica fino ad anni recentissimi (e ancora oggi c’è chi la rimpiange proprio per questo punto specifico). Che questa distinzione sia non solo del tutto ideologica ma anche dannosa lo mette in luce già nel 1956 Edward Snow in un saggio destinato a suscitare più polemiche che riflessioni: si intitola Le due culture ed esce sulla rivista the New Statesman il 6 ottobre. Scrive Snow: la nostra civiltà vede come intellettuali soltanto i letterati, del resto sono loro stessi a proclamarsi tali. Il resto è tecnica, non pensiero. «Ricordo un contro-interrogatorio al quale mi sottopose un famoso scienziato: “Perché nella maggior parte gli scrittori hanno opinioni sociali che sarebbero state giudicate palesemente incivili, e fuori moda al tempo dei Plantageneti? Non è forse così per quanto riguarda la maggior parte dei più famosi scrittori del ventesimo secolo? Yeats, Pound, Wyndham Lewis, nove su dieci di coloro che hanno dominato la sensibilità letteraria dei nostri tempi, non furono forse, politicamente, non soltanto ottusi, ma addirittura scellerati? Non è stata forse l’influenza di tutto ciò che essi rappresentano a portare tanto più vicino Auschwitz?» (Snow, 1959).
«Leggere Eschilo o Shakespeare , non parliamo di «insegnarli», come se i testi, come se l’autorità dei testi sulla nostra vita, fossero immuni dalla storia recente, è analfabetismo sottile ma corrosivo. […] Noi veniamo dopo. Adesso sappiamo che un uomo può leggere Goethe o Rilke la sera, può suonare Bach e Schubert, e quindi, il mattino dopo, recarsi al proprio lavoro ad Auschwitz. Dire che egli ha letto questi autori senza comprenderli o che il suo orecchio è rozzo, è un discorso banale e ipocrita» (Steiner, 2006).
Insisto su questo punto perché in molti oggi attribuiscono al presunto “prevalere della cultura scientifica” su quella classica, la fine della scuola, dell’alfabeto, della civiltà stessa nei suoi fondamenti.
Ma torniamo alle riforme: l’Italia repubblicana eredita dunque dal passato una scuola dall’impostazione liberale modernizzata in senso autoritario dal fascismo e la conserva aggiustandola in chiave democratica secondo il dettato costituzionale che individua nell’analfabetismo di molti e nella mancata scolarizzazione uno dei più importanti ostacoli da rimuovere dopo il 1946 (De Mauro). Gli anni Cinquanta, nella loro immobilità istituzionale, sono tuttavia attraversati da un dibattito vivace che darà frutti per tutti gli anni a venire: c’è l’influsso del Dewey pedagogista e l’inizio di un pensiero comunista sulla scuola che vanno a mettere in discussione la granitica egemonia cattolica sull’educazione.
I programmi Ermini per la scuola elementare del 1955 risentono di questo dibattito e, pur facendo riferimento a una filosofia spiritualistica di matrice cattolica, subiscono l’influsso della psicologia dell’età evolutiva che incominciava a diffondersi in quegli anni in Italia: Jean Piaget, ma anche Célestin ed Elise Freinet, Aldo Agazzi e Mauro Laeng. La scuola diventava un tema trasversale e molte sono le riviste che nascono: «Riforma della scuola», «Scuola e città», «Orientamenti pedagogici»; mentre parallelamente si costituiscono organizzazioni professionali di insegnanti, come il Movimento di cooperazione educativa (MCE). La questione della lingua affrontata in termini di lotta all’analfabetismo si fa strada nel dibattito pubblico anche se non tutti, ancora, le danno la stessa importanza (Roghi, 2017).
Scrive Mario Lodi, che del MCE fa parte: «noi eravamo una minoranza, che era arrivata al massimo ad avere 7.000 adesioni, nei confronti dei 220.000 maestri della scuola italiana; però eravamo fortemente motivati dal fatto che noi, pur non avendo mai vissuto in libertà, perché avevamo frequentato la scuola “del fascismo”, ora, caduta la dittatura fascista, vissuta la liberazione, avevamo la nuova legge da interpretare e insegnare. E fu proprio la Costituzione italiana, che ci ha messo in crisi, con l’art. 21, che diceva e dice tuttora: “Tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo”. Ecco, noi siamo stati buttati allo sbaraglio quando abbiamo vinto il concorso magistrale. In quelle condizioni, di fronte ad un problema così grande; come potevamo insegnare la libertà noi che non l’avevamo vissuta? Che cosa voleva dire “e ogni altro mezzo”?» (Lodi, ).
Per molti insegnanti quell’«ogni altro mezzo» è l’educazione linguistica che diventa il filo rosso intorno al quale ruotano le sperimentazioni migliori dei successivi venti anni di didattica: linguistica non significa esclusivamente insegnamento della lingua italiana, come raccontano i numerosi interventi del matematico Lucio Lombardo Radice; l’educazione linguistica investe anche la didattica della matematica (Maria Teresa Gentile, Educazione linguistica, crisi di libertà, Roma 1966). La questione della lingua (è un problema che viene da lontano, da Graziadio Isaia Ascoli a Manzoni, fino a Gramsci, ma anche G. Lombardo Radice e il problema del dialetto) è centrale nella cultura italiana dei primi anni Sessanta. Tullio De Mauro pubblica la sua Storia linguistica dell’Italia unita nel 1963, l’anno in cui entra in vigore la nuova legge sulla media unica, la legge numero 1859, promulgata il 31 dicembre 1962, nella quale si stabilisce che tutti i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni devono andare a scuola, nella stessa scuola, ma che solo quelli che hanno superato un esame di latino possono entrare, dopo, al liceo classico. Dopo un lungo dibattito, favorita dal nuovo clima di centro-sinistra, la riforma della scuola media pone per la prima volta agli insegnanti il problema dell’apprendimento dell’italiano oltre una soglia minima condivisa del leggere e scrivere e far di conto sulla quale si fonda la scuola elementare.
Nel 1962 i bambini che terminano il loro percorso di studi dopo le elementari sono 65 su 100; per passare alle medie è indispensabile un esame di ammissione. Pochi figli di operai o contadini possono permettersi di farlo. Per loro ci sono le scuole di avviamento professionale. Per le bambine spesso neanche quelle. La resistenza alla legge 1859 è enorme: d’altra parte, si chiede a docenti non preparati per farlo uno sforzo inedito nei confronti della lingua italiana; per quanto riguarda la storia si dice che, a causa della composizione sociale variegata, i docenti devono modulare il loro linguaggio a seconda delle scuole in cui operano (Roghi, 2017).
Così sono molti i professori e le professoresse che la patiscono, questa riforma: «La scuola media è ridotta a quello che è una scuola post elementare, fra poco una scuola per netturbini… Nelle superiori c’è più soddisfazione, gli elementi sono più selezionati, provengono da ambienti culturali superiori». «Preferisco la media superiore. Oggi è molto difficile insegnare nella media inferiore. È un brutto momento. Non si possono sfruttare le doti degli alunni meritevoli. Non si può bocciare, bisogna portare avanti tutti, livellare…». «In questo tipo di scuola media si diventa ignoranti. Ci starebbero meglio degli insegnanti elementari […] sanno poco anche l’italiano […] ci sono elementi più rozzi». «Nonostante ritardi evidenti e drastici tagli di spesa, le valutazioni impietose dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e una generale tendenza al catastrofismo, fino a oggi la scuola reale si è dimostrata assai più vitale e capace di rigenerarsi di quanto non traspaia dal dibattito pubblico. Secondo un sondaggio realizzato da Demos per “la Repubblica” nell’estate del 2016, l’istruzione pubblica è al terzo posto tra le istituzioni che più riscuotono la fiducia dei cittadini (56%), dopo papa Francesco e le forze dell’ordine. Che siano immagini discutibili e contraddittorie lo provano anche le accuse rivolte di recente alla scuola di non riuscire più a insegnare neanche l’italiano scritto e parlato, di cui i giovani sembrano sempre più ignorare l’ortografia, la grammatica, la sintassi» (Galfré, 2017).
L’accesso di tutti, peraltro solo potenziale, visto che altissimo è ancora il numero dei ragazzi che nei primi anni Sessanta non frequentano le medie, abbassa il prestigio stesso degli insegnanti, o almeno questo è quanto percepiscono molti di loro: «il prestigio degli insegnanti medi è diminuito perché la scuola media è diventata scuola di popolo, si è svilita in seguito alla riforma […] il livello sociale dei genitori e degli allievi è molto diminuito […] l’insegnamento è sceso al livello del popolo». E non manca una previsione per il futuro: «Il prestigio dell’insegnante resterà immutato. La situazione sociale e politica attuale sta andando verso sinistra. Le distanze fra gli strati sociali diminuiscono, il rispetto viene meno. Io sono democratica, ma anziché elevare il livello generale, c’è una tendenza ad abbassarlo» (Dei Barbagli, 1969).
La scuola nuova, coi suoi propositi, nonostante l’impegno di isolati docenti rimane sulla carta e ancora nel 1970 metà delle «coorti» o classi anagrafiche non raggiunge la licenza dell’obbligo. Neanche il Sessantotto (che incide soprattutto sulla secondaria superiore) modifica nell’immediato la scuola in senso più democratico e inclusivo. La scuola media dell’obbligo è ripensata davvero e davvero adeguata ai suoi compiti, almeno nei programmi, soltanto nel 1979 come conseguenza della legge 348 del 1977 che amplia le materie di insegnamento.
Dello stesso anno è la fondamentale legge 517 che prevede all’articolo 2 per la scuola elementare e all’art. 7 per la scuola media, la programmazione educativa «che può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni». La scuola di tutti e per ciascuno, in relazione con i soggetti che la abitano e con i territori (viene prevista l’apertura degli edifici ad attività estive ed esterne in comunione con province e comuni). Vengono abolite le classi differenziali e gli studenti disabili inseriti nelle classi (ricordiamo che gli insegnanti di sostegno previsti dalla legge diventeranno organici di fatto solo nel 2015 con la legge 107).
«L’avvio della programmazione didattica, e le indicazioni specifiche per il Collegio dei docenti, per i consigli di classe la scansione di verifica bimestrale, la compilazione della scheda personale dell’alunno, le osservazioni sistematiche, la valutazione trimestrale, da comunicare ai genitori, (art.4) sono tutte norme che, lette a distanza di quarant’anni, fanno riflettere sulla dimensione innovativa della legge 517 e quanto strada ha fatto la scuola italiana nel cammino dell’integrazione». Anche il dialogo scuola famiglia viene previsto per legge (art.9 che “gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci, i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell’alunno”). La scuola dell’inclusione, quella stigmatizzata da Paola Mastrocola, fra gli altri che però, evidentemente, non capisce assolutamente a cosa si riferisca questo sostantivo, come è evidente quando scrive: «Ha vinto l’idea di inclusione. Si è pensato che tutto ciò che era fuori dal comune (magari bello, grande, alto, difficile) fosse di per sé esclusivo e quindi brutto e cattivo. Era il Male. Non s’è capito che “invece era solo diverso, e che la diversità arricchisce il mondo. Abbiamo avuto paura della diversità, e l’abbiamo abbinata all’idea di esclusione. Così l’abbiamo, democraticamente, fatta fuori. E a scuola abbiamo cominciato a scendere dalla cattedra, a dare del tu agli allievi e a mettere i banchi in cerchio, in modo che non ci fosse un superiore e degli inferiori, ma tutti pari, tutti amici. E a breve, ci dicono gli illuminati riformisti del futuro, non ci sarà più la cattedra, e nemmeno la classe» (Mastrocola, 2011).
Sono passati dieci anni da quella che in molti individuano come la frattura più grave nel sistema dell’istruzione pubblica, il Sessantotto appunto, ma la maggior parte delle trasformazioni che avvengono nel decennio nasce da percorsi molto più antichi ed è figlia della generazione precedente, quella che inizia a ragionare di scuola intorno agli anni Cinquanta. Solo nel 1985 la scuola elementare e nel 1991 quella dell’infanzia vedono modificare profondamente i loro programmi. «Avvenne allora un fatto straordinario, senza precedenti e repliche: per iniziativa della ministra dell’epoca, Franca Falcucci, i programmi non furono solo emanati, ma attraverso un sistematico piano di aggiornamento furono per due anni oggetto di studio e assimilazione da parte di tutte e tutti gli insegnanti e così questi due ordini di scuola decollarono e, come è noto, presero a collocarsi in vetta alle classifiche internazionali di apprendimento degli alunni» (De Mauro, 2017 1ed 1963).
I mutamenti della secondaria superiore, invece, sono soprattutto legati a sviluppi quantitativi e non qualitativi: il liceo classico ha continuato a fare il liceo classico allo stesso modo fino ai giorni nostri. Così l’istruzione professionale. Quello che è cambiato invece è il numero di iscritti che ne hanno radicalmente trasformato il ruolo sociale e la fine della diseguaglianza legata al genere. Negli ultimi anni la percentuale di iscritti nei licei è aumentata, si è stabilizzata quella nei tecnici, ma intorno al 30%, e quella dei professionali è crollata. Inoltre, quello che conta è il contesto di riferimento: i dati degli anni novanta sono ancora riferiti a un periodo in cui il tasso di scolarizzazione tra i 14 i 19 anni era intorno al 70% (un balzo in avanti rispetto ai decenni precedenti), mentre oggi siamo quasi al 100% se si conta anche la formazione professionale. Questo spiega il ridimensionamento dei classici, mentre il successo generale dei licei ha altre cause. (Piras, 2019)
A partire dagli anni Settanta, le sperimentazioni hanno rivestito un ruolo suppletivo rispetto a riforme generali che con scadenza periodica venivano (e vengono) annunciate. Tuttavia alcuni provvedimenti hanno inciso in modo radicale sulla scuola nel suo complesso: l’autonomia scolastica del 1997, la riforma Berlinguer e la riforma Moratti.
La delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, Legge 15 marzo 1997, n. 59 (decreto Bassanini), all’articolo 21 traccia le linee guida dell’autonomia scolastica: ogni istituto deve dotarsi di un piano triennale dell’offerta formativa che favorisca la flessibilità oraria, percorsi didattici individualizzati, percorsi formativi in coordinamento con le richieste del territorio. Molto bello sulla carta, in realtà contraddittorio nell’applicazione, si trasforma nella cartina di tornasole della diversa preparazione non solo nella didattica di dirigenti e insegnanti, la scelta di convogliare risorse su un progetto piuttosto che un altro racconta in modo nitido quale idea di scuola e di stato abbiano i diversi istituti scolastici e inoltre apre la strada a uno dei tormentoni più fortunati degli ultimi anni: gli insegnanti sono diventati dei passacarte, la scuola è stata ridotta a un gigantesco esercizio di burocrazia.
La riforma Berlinguer, legge 30 del 2000, imposta una modifica strutturale dell’insegnamento, articolato in tre cicli: la scuola dell’infanzia; il ciclo primario (scuola di base), esteso a otto anni come nel modello francese, comprendente le elementari e le medie, proiettato alla preparazione agli studi successivi. Il ciclo secondario, esteso a cinque anni e articolato in cinque differenti aree: umanistica, scientifica, tecnica, artistica e musicale e concluso dall’esame di Stato. Ma non viene mai applicata. Tuttavia è ancora oggi vista come uno spartiacque periodizzante: come scrive Fabio Fiore, poco dopo la sua promulgazione ha l’effetto di polarizzare il dibattito in due partiti ancora oggi contrapposti, il partito della rincorsa e il partito della resistenza. Rincorrere cosa, resistere a chi? Rincorrere le “novità” pedagogiche che rivendicano un uso più intelligente e disinvolto dei media (Maragliano) e invitano a riscoprire la parte bambina di sé per una scuola meno autoritaria e più partecipata (Carotenuto, 1995). Resistere a chi? A tutto, verrebbe da dire, ripercorrendo la vasta schiera di studiosi che interviene in questo volgere di millennio in reazione a quello che Lucio Russo chiama “l’asse Maragliano- Berlinguer”: Giulio Ferroni parla di senso di catastrofe che grava sulla scuola; Giovanni Sartori di degrado e cattiva pedagogia; Luicio Russo di scuola per consumatori. Uniti dal rifiuto degli strumenti informatici (a meno che non vengano usati seriamente) di fatto fondano autorevolmente un discorso ancora oggi largamente diffuso fra gli specialisti e i commentatori.
La scuola proposta da Ferroni è una scuola di alto livello, capace di mantenere una certa discontinuità con la vita, una distanza e non adattamento alla realtà. Una scuola che nei fatti esiste solo nella sua testa, o forse nella sua esperienza, sua e di altri pochi eletti. Storicamente, infatti la scuola è una cinghia di trasmissione potente di valori e modelli sociali anche quando rivendica questa distanza dalla realtà.
Anche grazie a questo muro di opinioni negative viene facile al governo di centro destra guidato da Silvio Berlusconi fare un passo indietro. Nel 2003 la riforma Moratti abroga di fatto la legge 30, trasformando l’obbligo in diritto-dovere di istruzione fino ai 18 anni (che si può assolvere anche nella formazione professionale, nell’apprendistato) (Dlgs 76/2005). L’obbligo è portato a 16 anni, nel 2006 da Fioroni: Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La riforma dei cicli è archiviata e rimane ai ragazzi e alle ragazze una scuola non omogenea che li pone di fronte a un bivio a 14 anni, bivio sul quale pesa come un macigno il consiglio orientativo delle scuole medie, una delle cause storiche di quello scoraggiamento a cui largamente imputiamo l’abbandono scolastico (Save the children, 2017).
Ora appare evidente che questa lista di provvedimenti da sola no basta a raccontare la scuola e la sua storia: la scuola infatti è un corpo sociale che in qualche modo anticipa le riforme o le subisce, ma raramente le fa sue in toto, al punto tale da non poter identificare in età repubblicana una scuola come la scuola di Ermini o la scuola di Berlinguer o la scuola della Falcucci. La scuola si affaccia su una strada, un paese, una città, è fatta di esseri umani, la scuola assomiglia ai suoi tempi, ma, come scriveva don Milani anche al passato e al futuro, anzi li lega insieme: «La scuola siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi» (Milani, 1965).
Come nel caso della riforma delle medie, vecchio e nuovo convivono, senza andare d’accordo, in aperto conflitto, in forme esplicite o striscianti, dando vita in modo carsico e molti anni dopo a colpi di coda che riportano indietro la lancetta della storia di anni, se non di decenni. Identificare il discorso sulla scuola con il discorso sulle riforme dunque non basta, perché poi è l’insegnante con il suo portato culturale, la sua storia personale, i suoi desideri, a chiudere dietro di sé la porta dell’aula ed entrare in relazione con i ragazzi. Come farlo è una scelta che da sempre compete a lui o a lei che prescinde da ogni riforma.
Molto più importante è il livello di investimenti e le politiche relative alla formazione e all’entrata in ruolo del personale docente: sarebbe interessante per esempio verificare quanto le linee guida sulle competenze di Fioroni del 2006 siano state collegate alla legge 107/2015 detta della buona scuola, pur provenendo da contesti assai diversi e assimilate come unico tentativo di distruggere definitivamente il sistema scolastico, ma sarà argomento di un’ulteriore riflessione.
Torniamo allora all’inizio di questo intervento, all’ordine del discorso sulla scuola. Prima di ragionare di riforme (ed è indispensabile farlo in chiave storica, insisto), prima di prendersela con qualcosa o qualcuno, abbiamo bisogno urgente di rifondare il linguaggio, di un’ecologia del discorso sulla scuola che metta a punto parole e concetti che, sfrondati dalla retorica e fasulla contrapposizione fra un oggi orribile e un’età dell’oro tanto vaga quanto imprecisata, faccia da fondamento a ogni futuro intervento. Come scriveva George Lakoff, se nella nostra visione del mondo si affermano false divisioni temporali, parole mutuate dal gergo bellico per parlare di scuola, allora concepiremo pensieri che non riescono a prescinderne, come quando qualcuno vi dice: non pensare all’elefante rosa. «Queste metafore si radicano nel profondo della nostra mente, e hanno la caratteristica di rimanervi anche quando i contenuti che veicolano sono andati via. Lakoff sostiene che il radicamento è addirittura sinaptico: possiamo dubitarne, ma non è poi necessario arrivare a questo livello neurolinguistico per accettare il fatto che le metafore restano anche quando i contenuti sono andati via. Come l’immagine dell’elefante che vi ho messo davanti agli occhi, e che non andava via anche quando voi cercavate di non pensarci» (De Michele, 2010).
Dobbiamo avere chiaro cosa significa scuola, per noi, oggi, chiederlo magari anche ai ragazzi (Batini, 2018) e poi occuparci seriamente della realizzazione di una vera uguaglianza in materia educativa che «dovrebbe passare dalla costruzione di corsi comuni per tutti gli allievi fino a 16 o 18 anni. In seguito bisognerebbe cercare di smussare tutto quello che sul piano materiale può creare degli ostacoli alla scolarizzazione dei bambini provenienti da famiglie socialmente sfavorite, instaurando il principio della gratuità totale dell’educazione compresi i pasti, i trasporti e il materiale scolastico» (Pfefferkorn, 2007). Dunque: riforma dei cicli e gratuità dei servizi di base come prerequisiti fondamentali.
E poi una rivoluzione interna alla scuola che metta al centro la relazione scuola/ragazzi più importante di ogni contesto ambientale, politico o legislativo. Infatti, al disagio della famiglia di origine può corrispondere un percorso scolastico eccellente là dove la scuola bilancia in termini di fiducia e motivazione e istruzione; mentre per lo scoraggiamento, l’umiliazione, non esistono cure sistemiche, e questo è un dato strutturale della storia della scuola se, fin dall’Inchiesta voluta dal ministro Guido Gonnella del 1947 possiamo leggere che «le ingiustizie più grandi nella scuola si consumano nell’invisibile» (Gonella, 1947).
Le soluzioni sono ancora oggi scritte in un libricino uscito nel 1967 da un gruppo di ragazzi del Mugello e un prete, don Lorenzo Milani, si intitola Lettera a una professoressa. A quelli che sembrano cretini dargli la scuola a pieno tempo. Agli svogliati basta dargli uno scopo. Non bocciare.
Non bocciare. Su questo, in effetti, c’è ancora molto da lavorare in termini di senso comune. I ragazzi stessi sono dubbiosi, proprio perché, tendono ad attribuirsi gran parte della responsabilità dell’insuccesso formativo (Batini, 2018). Quando si parla della necessità di non bocciare ci si riferisce all’obbligo scolastico, l’obbligo scolastico oggi finisce a 16 anni. Ma è possibile non bocciare nel biennio delle superiori? Ci sono due questioni: i risultati di apprendimento sono di fine biennio: nessuno dovrebbe essere respinto in prima, visto che lo Stato non definisce obiettivi per la fine della prima. Il biennio è un’unica campata. Trattandosi di obbligo scolastico, e essendo la scelta affidata liberamente all’alunno, si dovrebbe consentire di terminare l’obbligo dove si desidera. Il biennio non è più l’inizio del percorso che porta al diploma, ma la fine di un corso decennale (Giusti, 2019).
Il tempo pieno. Nell’ultimo documento del MIUR sulla dispersione scolastica del gennaio 2018 non c’è mai l’espressione tempo pieno. Si accenna alla necessità di un tempo scuola migliore e si parla di tempo prolungato, di dedicare tempo a ciascun ragazzo. Ma non si dice mai: occorre rivedere la legge sull’autonomia scolastica al fine di garantire il tempo pieno a tutti. Occorre mettere radicalmente in discussione la gerarchia del bilancio dello stato in funzione della Pubblica Istruzione. Occorre investire sui corsi di recupero che ora sono in gran parte una presa in giro, tanto che le ripetizioni private rappresentano un mercato in costante espansione al punto che i genitori le fanno prendere ai figli ancor prima che l’insufficienza si manifesti. Obiettivo della scuola di base dev’essere quello di superare la forza del contesto socioeconomico nel percorso degli alunni, e lo può fare se ha risorse e “tempo”, solo così è possibile superare le determinazioni sociali ed economiche ancora oggi importanti. In questo senso gli istituti comprensivi sono una risorsa ancora non bene utilizzata dal sistema e le “indicazioni nazionali” del 2012 un testo culturalmente importante ma che necessita di gambe e risorse (Adagio, 2019). La buona scuola in tale direzione è stata fallimentare, pur mettendo a disposizione maggiori risorse economiche del passato ha concentrato il “potenziamento” sulla scuola secondaria di secondo grado.
Nessuna buona intenzione, nessuna anagrafe, nessuna cabina di regia contro la dispersione può funzionare se non si dice con chiarezza questo. Serve più tempo scuola. Di migliore qualità. Pieno anche della presenza di ragazzi e ragazze: quando il tempo pieno è stato istituito era popolato di laboratori, tipografia, falegnameria, biblioteca. Oggi si tratta nella gran parte dei casi di raddoppio dell’orario scolastico. Tutto. Ma chi già non regge sei ore come può reggerne otto? E il tempo pieno torna a essere la scuola che cura i sani e respinge i malati (Maestri di strada, 2018).
Senza che venga risolta questa enorme ingiustizia che rende la scuola uguale la mattina e diversa il pomeriggio non è pensabile poter bocciare, neanche oggi, neanche con questa assurda e anacronistica organizzazione dei cicli scolastici.
Perché, infine, si domanda Fiore già nel 2002, un non specialista, lo storico, dovrebbe prendersi a cuore la materia scolastica? Perché, come lui stesso rileva, la crisi messa in atto dalle trasformazioni degli ultimi venti anni induce alla nostalgia di un pensiero forte, prescrittivo, in grado di indicare cosa fare e cosa non fare, alla storia, dunque, si chiede di indicare cosa recuperare dal passato perché il presente non piace, non va. Le competenze appaiono troppo evanescenti, e invece di essere assunte come una chiamata alla responsabilità, diventano il correlato oggettivo di tutta la fuffa pedagogica (Giunta, 2018) che avrebbe reso i ragazzi dei bamboccioni balbettanti un linguaggio twittesco (Galli della Loggia, 2018). Lo storico allora ha il compito di restituire la complessità di un passato dove vecchio e nuovo hanno sempre convissuto, dove la crisi è sempre esistita, dove gli insegnanti si sono sempre sentiti (legittimamente) sminuiti, di una lunga durata che ha visto sempre il paese diviso in due (forse anche tre) Italie. Ma anche di fratture determinanti che non sono soltanto il ‘68, ma la riforma delle scuole medie, non la legge 30, ma, molto più seriamente, i tagli alla scuola pubblica. Soltanto così il passato può diventare utile al presente: capovolgendo la visione dell’angelo di Walter Benjamin chi usa il passato in modo necrofilo vede le macerie tutte davanti a sé e vedendole le trasforma nell’elefante rosa che vedono tutti: a forza di dire che la scuola fa schifo, la scuola farà schifo a tutti.
Ma a scuola ogni giorno entrano migliaia di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, il nostro compito di adulti è quello di offrire loro un’istruzione di qualità, a tutti i livelli per avere fiducia nei confronti del presente, del futuro e soprattutto di loro stessi. Occorre essere seri e attenti per essere padroni del nostro tempo: seri e attenti e responsabili. Non si può invocare l’autorità se non si riesce ad essere autorevoli, non si può essere autorevoli se si sparano date, dati, storie a casaccio al fine di legittimare un pregiudizio: che la tradizione sia stata spazzata via per lasciare il posto alla fuffa. Oltre al fatto che non ogni tradizione è buona di per sé, questo discorso è falso: basta entrare in tre classi di scuole diverse per rendersene conto, tradizione novità e anche una certa fuffa convivono da sempre nel sistema scolastico e non è chiaro quale di questi tre termini sia preferibile.
Bibliografia
Non studio, non lavoro, non guardo la tv. Quaderno di lavoro del V convegno biennale sull’orientamento narrativo, cura di F. Batini e S. Giusti, Pensa Multimedia, Lecce 2015
M. Galfrè, Tutti a scuola. L’istruzione nell’Italia del Novecento, Carocci, Roma 2017
C. Raimo, Tutti i banchi sono uguali. La scuola e l’uguaglianza che non c’è, Einaudi, Torino 2017.
S. Parrello, Scene dal futuro. Adolescenza, educazione e distopia, Franco Angeli, Milano 2018
Il saggio è uscito per la prima volta qui